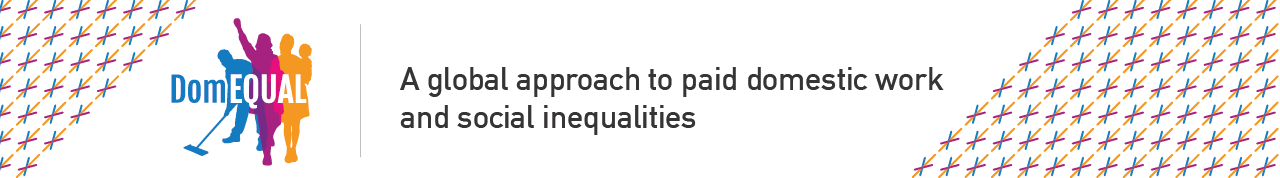Il 17 e il 18 marzo presso l’Università Ca’ Foscari di Venenzia si è tenuto il simposio Global views on paid domestic work. Da questo incontro che lancia l’inizio del progetto DomEqual, sono emerse due importanti indicazioni: la necessità di intensificare le connessioni e il dialogo tra ricercatrici di diverse discipline e tra queste e gli/le attiviste che promuovono maggiori diritti per le lavoratrici domestiche e di cura, e il tema dell’intersezionalità come categoria di analisi per osservare le diverse forme di discriminazione che contraddistinguono questa occupazione e che contribuiscono a generare sistemi globali di cura ineguali. Di seguito, in sintesi, quelli che sono stati i diversi interventi che hanno animato queste giornate.
La sfida in una prospettiva storica
Dirk Hoerder, dell’Arizona State University, ha aperto la prima sessione focalizzandosi su tre punti principali: come si è andato a definire nel corso della storia il lavoro domestico anche nella sua trasformazione terminologica e figurativa, come l’analisi storica di questa occupazione dovrebbe contribuire a determinare le ragioni del suo mancato riconoscimento sociale e come l’autoconsapevolezza di essere “altro” abbia contribuito in alcuni casi, a rafforzare la posizione del lavoratore verso il datore di lavoro a proprio vantaggio. L’ “alterità” si costituisce in forza quando la consapevolezza di essere “altro” è alla base di un processo di organizzazione collettiva. Quindi si è riportato il caso delle lavoratrici migranti finlandesi che vivevano e lavoravano tra gli anni ’20 e gli anni ’30 su entrambi i lati del permeabile confine USA-Canada. Con il supporto del movimento comunista finlandese, si unirono per dare vita ad agenzie per il lavoro, reti di informazione e supporto. Una forte coscienza a partire dalla stessa condizione di migranti, ha permesso a queste lavoratrici di essere determinanti anche nei casi di lavoro forzato. Le pratiche utilizzate da queste lavoratrici sono simili a quelle che più di un secolo dopo avrebbe perseguito l’International Domestic Workers’ Federation (IDWF).
Un approccio che tenga conto dell’intersezionalità deve essere sostenuto dalle connessioni e dal dialogo che si crea tra storici e ricercatori di scienze sociali. Questo è stato il messaggio principale dell’intervento di Raffaella Sarti, dell’Università di Urbino. Per molto tempo si è sostenuta l’opinione comune che il lavoro domestico sarebbe scomparso con lo sviluppo economico, così l’interesse accademico, soprattutto di tipo storico, verso questo tema è stato scarso fino agli anni ’70. I ricercatori sociali hanno affrontato il tema dei servizi domestici solo parzialmente, come fenomeno relativo ai paesi in via di sviluppo. Sarti ad esempio cita Ester Boserup che applica la teoria dello sviluppo economico ai servizi domestici. Solo con l’inizio degli anni ’90 si è iniziato a sollevare il tema dello sfruttamento, a pensare a come e in quali forme il lavoro domestico potesse rappresentare una forma di “schiavitù moderna”. Gli anni successivi sono quelli dell’attivismo politico durante i quali le lavoratrici domestiche si sono imposte sulla scena globale con maggiore visibilità. Un momento che ha accompagnato la Convezione ILO n.189 del 2011 ed è proseguito con l’assemblea internazionale delle lavoratrici domestiche nel 2013. Il maggiore protagonismo delle lavoratrici domestiche ha favorito l’esplosione dell’interesse accademico dal 2010 fino a oggi, spostando il lavoro domestico dai margini al centro della ricerca. Sarti suggerisce di cogliere l’occasione per sviluppare una storia globale del lavoro domestico.
Genere e cura in una prospettiva globale
Rhacel Parreñas della University of Southern California (che abbiamo intervistato, ndr) ha iniziato la seconda sessione evidenziando alcuni problemi e limiti del discorso che lega il lavoro domestico al tema del traffico di esseri umani e del lavoro forzato. A livello regolamentare, le definizioni di traffico e schiavitù sono tecnicamente inesatte perché spesso sottintendono tre elementi – la delocalizzazione, l’inganno e lo sfruttamento – che tendono a vittimizzare le lavoratrici domestiche e a sminuire il ruolo delle agenzie di reclutamento. Le lavoratrici domestiche solitamente, non vengono ingannate perché scelgono consapevolmente di entrare in servitù. Questa è una relazione di proprietà, un rapporto di dominazione estrema, ma non necessariamente diventa una relazione di controllo. L’utilizzo di questi termini non riconosce le lavoratrici domestiche come agenti attive e produce ulteriori problemi nella letteratura. Questa in genere si basa su un’analisi funzionalista delle condizioni legali dei lavoratori domestici riducendo la condizione forzata ai soli dispositivi che (non) la regolano. Allo scopo di superare questo limite, Parreñas ha condotto una ricerca a Dubai e Singapore, considerati paesi di destinazione problematici, coinvolgendo oltre alle autorità ufficiali, datori di lavoro e agenzie di reclutamento, anche 282 lavoratrici migranti. I risultati mostrano che gli atteggiamenti culturali verso il lavoro domestico sono tre: la disumanizzazione, l’infantilizzazione e il riconoscimento. Tale diversità si spiega dal fatto che anche il lavoro forzato è un’esperienza moralmente mediata e che prende forma non solo in base alle regole, ma anche attraverso le culture, i valori e le ideologie dei diversi paesi. Quindi anche a partire da questi elementi riusciamo ad individuare le diverse articolazioni dei mercati globali di cura.
Con “riproduzione sociale” ci si riferisce alla produzione delle persone sia dipendenti che indipendenti, alle varie forme di lavoro e di risorse economiche, sociali e istituzionali, necessarie a mantenere i singoli e le famiglie, che opera sia nei paesi di invio che in quelli di ricezione. Secondo Eleonore Kofman della Middlesex University, riprendere un concetto classico come quello della riproduzione sociale risulta particolarmente efficace per studiare la mobilità internazionale contemporanea. Le politiche migratorie dirette ai lavoratori domestici e di cura infatti hanno un impatto limitato sulle lavoratrici migranti poiché molte si regolarizzano attraverso i ricongiungimenti familiari. Questo è vero per molti paesi europei, come Francia, Svezia e Spagna. In Asia, le famiglie di classe media o ricca cercano lavoratrici domestiche straniere mentre le famiglie appratenti a classi più basse cercano mogli straniere. Allo stesso modo la crisi della riproduzione sociale mossa da deficit di cura, di tempo e di lavoro, sono state alla base del processo di esternalizzazione delle attività di cura e domestiche al mercato avvenuta in Europa.
La dimensione migratoria in questione
L’ultima sessione è iniziata con l’intervento di Rosie Cox, della Birkbeck University of London, che ha descritto le connessioni tra la figura della ragazza alla pari e quella della lavoratrice domestica migrante. A dispetto dell’opinione generale che vede il lavoro alla pari solo come uno scambio culturale, una prospettiva internazionale rivela che molto spesso anche nel caso delle lavoratrici alla pari si tratta di donne che provengono dal Sud del mondo che investono denaro e risorse per migrare in Europa o negli USA e che attraverso le rimesse contribuiscono a supportare le proprie famiglie nonostante molti paesi ne ostacolino il ricongiungimento. Spesso queste lavoratrici sono sottoposte allo stesso sfruttamento e gli stessi ricatti delle lavoratrici domestiche migranti, ma la loro posizione può essere più vulnerabile perché ancora meno regolamentata. Nella maggior parte dei casi, la figura della lavoratrice alla pari è disciplinata solo dalle norme in ambito migratorio e si possono identificare diversi modelli di regolamentazione: debole in Australia, UK e Irlanda, media in Francia e Nord Europa e forte, quindi simile a quella di una occupazione regolare, negli Stati Uniti. La ricostruzione nello spazio e nel tempo di questa nicchia di occupazione non ufficiale permette di rafforzare anche il tema delle discriminazioni che caratterizzano il lavoro domestico. È solo attraverso una prospettiva comparata, rilancia Cox, che si resiste a quelle analisi semplicistiche che riducono le pratiche di sfruttamento a meri casi isolati.
Per definire meglio i concetti di “catene di cura globale” (Hochschild, 2000) e di “divisione internazionale del lavoro riproduttivo” (Parreñas, 2001), Margarita Barañano Cid dell’Universidad Complutense de Madrid propone di arricchire l’approccio teorico alla dimensione spaziale. Questa infatti permette di superare la dicotomia che vede un paese ricevente e un altro destinatario e di capire in che modo il contesto conti sia dal lato dell’offerta che da quello della domanda. L’allargamento analitico a tale prospettiva mira a rintracciare le diverse scale spaziali (stati, spazio transnazionale, spazi sub-nazionali o locali) dove si ancorano e posizionano le catene della cura e a cogliere come le diverse modalità e sistemi di riproduzione sociale si configurano in base ai diversi contesti locali. Barañano Cid ha presentato l’esempio della Spagna con il suo retaggio comunitarista e colonialista. In questo paese il passaggio avvenuto da un sistema di welfare di tipo familista a un familismo transazionale si può leggere anche considerando, ad esempio, il peso della domanda di cura generatosi nelle grandi città e nelle metropoli. In città come Madrid e Barcellona, infatti, si concentrano il 37% delle lavoratrici domestiche che lavorano in Spagna.
Per comprendere le differenti configurazioni del lavoro domestico in ottica comparata, è necessaria un’analisi che intrecci diversi livelli: dal regime di cura o migratorio, ai sistemi di reclutamento e di formazione. Anche questi ultimi contribuiscono alla subordinazione delle lavoratrici domestiche migranti e al rafforzamento delle norme sociali di cura tradizionali. Seguendo questa impostazione, Pei-Chia Lan, della National Taiwan University, nell’ultimo intervento della sessione ha mostrato i risultati di un analisi applicata ai casi di Taiwan e del Giappone. In Taiwan il sistema del paese ospite permette di continuare a sostenere la tradizionale organizzazione familista della cura e questo si traduce in una formazione non professionalizzante, ma che enfatizza al contrario tutte le caratteristiche del lavoro di cura informale. Il Giappone invece recluta solo lavoratori qualificati e limita i luoghi di lavoro alle strutture di cura e agli ospedali. La formazione è di tipo assimilazionista e mira a colmare la distanze culturali.